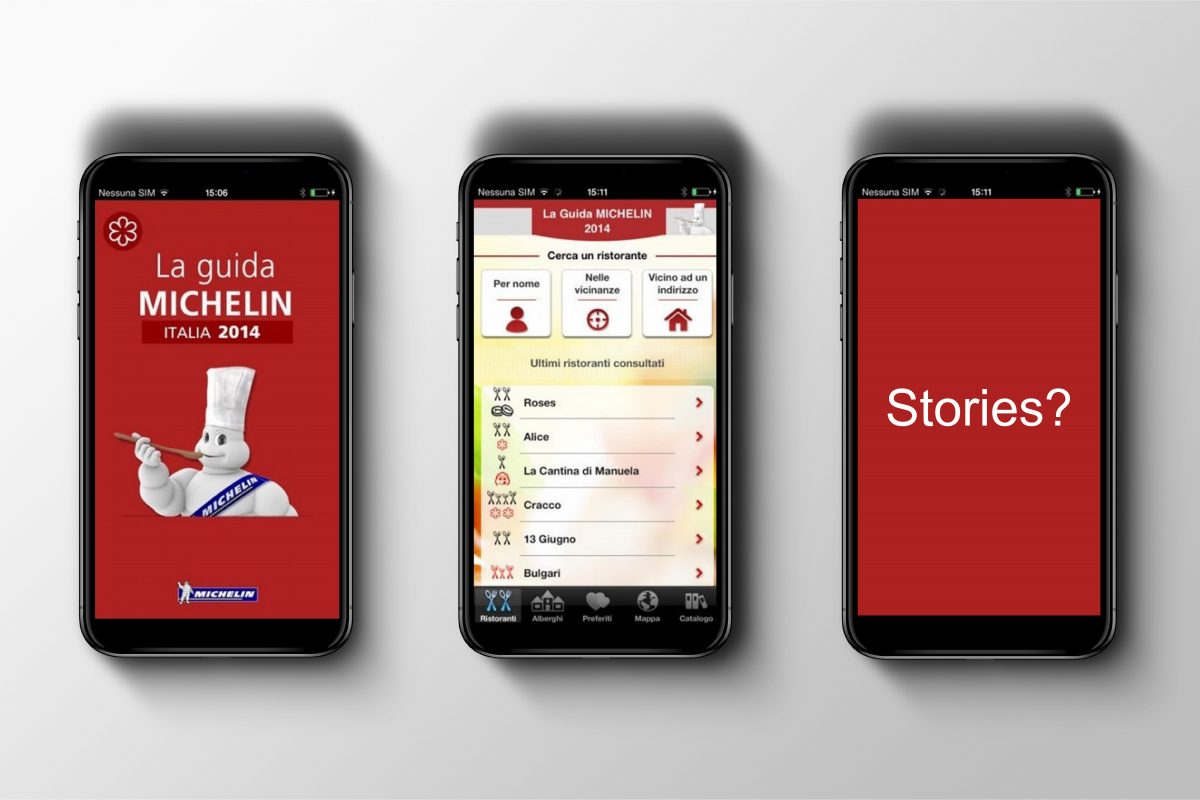Quasi un annetto fa, la mia ghostwriter preferita si è divertita a scrivere un articolo sulla difficile arte del copy e di come i diversi clienti possano interpretare il risultato del tuo output finale, ma oggi invece voglio raccontarvi come da una banale news si possa andare a creare un articolo complesso e avvincente su tematiche al limite del paranormale.
Partiamo dall’inizio. Ormai da quasi due anni, noi scriviamo in ghost per un’importante realtà che opera nel mondo della sicurezza informatica. Tematiche complesse, divertenti, di moda estrema, avvincenti a volte quasi al limite della fantascienza e delle scenografie di uno 007.
Verso la metà dello scorso mese, in una delle mie tante serate a caccia di informazioni attraverso il mio fidato feedly, che mi aggiorna su qualsiasi argomento mi interessi, sia personalmente che per i clienti per cui lavoriamo, trovo un articolo molto interessante relativo ad un contest che si doveva tenere da lì a poche settimane in USA sulle migliori start up che operano nel mondo della cyber security.
Come sempre faccio, faccio il mio clic sulla pagina e bang. Mi trovo davanti ad una pagina con i nomi di tutte le start up invitate a questo contest e soprattutto leggo che tutti i precedenti vincitori degli enne anni prima avevano fatto un salto carpiato triplo all’indietro da fermo nel mondo sia della sicurezza sia della finanza. Insomma delle aziende col botto.
Cerco informazioni, convinto ormai che nel magico mondo del web ci sia una splendida landing page di presentazione dell’evento, di spiegazione delle company invitate, dei loro possibili speech di presentazione e … NULLA!
Cavoli. E adesso? Avevo un argomento fantastico, attuale, di cui nessuno aveva parlato in Italia, molto sexy, molto tosto e … non c’era nulla che mi potesse servire come traccia per iniziare a scrivere?
10 aziende. 10 link a 10 siti aziendali. Ok Ale, qua tocca fare il lavoro sporco, come si faceva una volta. Vi confesso che è stato un colpo di genio. Una giornata intera staccato da ogni forma di comunicazione esterna, si ogni tanto Telegram e il mio telefono si lamentavano della mia assenza dal mondo digitale ma … mi sono perso dentro il mio processo di analisi, di valutazione e di racconto di tutte le aziende. Ovviamente gli skill non sono solo quelli di scrittura, nel pezzo di cui sopra si parla sempre del cliente, in pochi si soffermano sul fatto che pochi sanno scrivere bene, che il copy è un lavoro, come lo è il programmatore, il grafico, il designer, l’insegnante, il pilota …
Va beh, gli skill di scrittura mescolati negli skill di web copywriting mi hanno rapito in un mondo di tecnologia super avanzata dove la prima sfida era capire chi fosse l’amministratore delegato dell’azienda. Trovare il profilo di Linkedin – pazzesco come CEO di aziende che stanno per fare il botto non abbiano un responsabile della digital reputation che sistemi i loro profili Linkedin prima di andare a fare lo speech più importante della loro vita – poi andare a trovare la loro mission. Sì la mission. Perché è nella mission che le aziende americane raccontano cosa fanno per i loro clienti. Si magari.
Anche le aziende di sicurezza informatica che stanno per presentarsi allo speech della vita … non sono in grado di sintetizzare in una frase o due quale sarà il vantaggio pazzesco che il cliente avrà scegliendo il loro prodotto.
E dopo il why, tocca andare a spiegare il come.
Sì, perché se sul why alla fine qualcosa la riesci a raccogliere qua e là nel sito, è il come che diventa veramente un disastro.
Perché per spiegare come un’azienda farà la differenza nella soluzione del tuo problema devi: capire il problema, capire la soluzione, spiegare il primo e il secondo in maniera che sia comprensibile a tutti i lettori.
Beh vi confesso che per alcune aziende è stato semplice riuscire a spiegare cosa facessero e dove fosse quel guizzo di genialità che poteva fare la differenza e il motivo per cui erano state portate a quel contest. Quando si inizia a parlare di mappatura olistica del grafo di grafici di tutta l’architettura di programmazione di un software con “tutte le interconnessioni all’interno dei vari livelli di codice e permette di identificare rapidamente le fonti di data leak, vulnerabilità critiche e violazioni della sicurezza/ compliance in anticipo e lungo l’intero ciclo di sviluppo del software” … ehhhh???
Va beh alla fine è stato veramente divertente andare a scartabellare in pagine su pagine di siti internet dai contenuti più o meno intellegibili e farli diventare qualcosa di interessante e di utile per il cliente.
La cosa più divertente sapete qual è stata? Alla fine ha vinto l’azienda che mi aveva attratto all’inizio di tutta la storia. Si quella su cui avevo letto la notizia sul mio Feedly. Tra dieci aziende che potenzialmente avevano la possibilità di fare il botto, ha vinto quella che aveva attratto la mia attenzione fin dall’inizio.
p.s. ecco i link agli articoli di quanto abbiamo scritto:
State of the Art della Sicurezza Informatica – Better is Better parte 1
State of the Art della Sicurezza Informatica – Better is Better parte 2